
Corte Costituzionale su fine-vita. Una sentenza che poco sentenzia
La sentenza della Consulta sulla compatibilità fra la Costituzione e l’art. 580 del codice penale non è, a mio parere, né una conquista di libertà né la resa ad una visione utilitaristica della vita umana. È un atto ulteriore, anche questo limitato e circoscritto, al margine di un dramma di tale capacità deflagrante da non ammettere conquiste. Le posizioni di chi ritiene che da oggi, in questo Paese, ognuno abbia una possibilità in più o di chi, invece, pensa che la sentenza apra un varco alla cultura della morte, lasciano il tempo che trovano. I punti secondari dai quali si dovrebbe partire, sono due: il primo è che, in termini concreti, la sentenza non cambia tutto quello che sembra cambiare, perché la possibilità di rinunciare alle sole terapie salvavita in sedazione è già contenuta nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento (L. 219/17). Anzi: facendo riferimento alla necessità di accogliere il parere di un comitato etico territorialmente competente, la Corte Costituzionale sembra non considerare – nella nobiltà del principio – l’evidenza di una realtà per la quale questi enti non sono affatto definiti con precisione nel nostro Paese. Il secondo punto è ancora più inquietante, perché è grave che il Parlamento – per mancanza di volontà? Di capacità? Di tempo? – non abbia saputo dare soluzione ad un tema che, per evidenza stessa di logica, avrebbe dovuto trovare una risposta legislativa nella sua sede più naturale, giusta ed auspicata, come ha fatto notare lo stesso procuratore aggiunto di Milano. Un vuoto legisl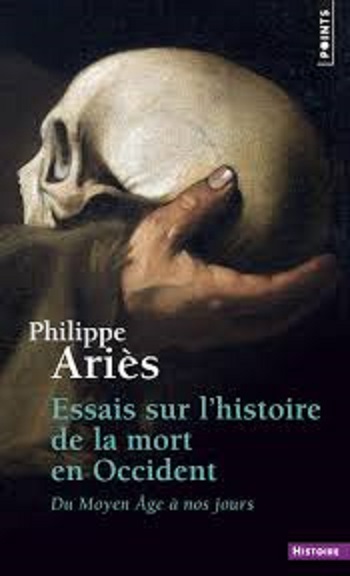 ativo è sempre un vulnus nell’organismo di uno Stato con pretese di civiltà, ma a volte può essere viceversa una garanzia. Labile o meno, ma una garanzia. È vero che una legge diventa a questo punto indispensabile, stante anche la manifesta «linea del Piave» dei medici cattolici, ma di fronte ad un Parlamento affaccendato con le scatole di merendine non risulta poi così stridente che spetti ai giudici, di volta in volta, esprimersi sui diversi casi. Persino il ministro degli esteri deve averlo intuito, perché ha auspicato, in un politichese asciutto, «un accordo per un testo equilibrato». Ha usato proprio questo termine: equilibrato. A dimostrazione della sua paura di «cattolico fervente», lui che contribuì a bocciare la legge sulle unioni civili, nonostante il sì di Rousseau, e del suo imbarazzo politico perché su questa eventuale legge si gioca la sorte di tutti gli esecutivi prossimi venturi. Per questo il problema è destinato, secondo me, a permanere a lungo, coperto e ben riscaldato dagli inutili scontri di principio. Cosa dovrebbero fare, più di questo, i giudici? Ora è semplice giubilare per la possibilità in più o sdegnarsi per il presunto smarrimento della ragione. Il punto primario è un altro ed è una questione di cultura. È dal 1975 che si parla della morte come fenomeno tecnico ottenuto interrompendo le cure: ne parlava un medievalista francese, Philippe Ariès, nel suo Essais sur l’histoire de la mort en Occident. Bisognerebbe ascoltare di più la serietà della storia. Bisognerebbe chiederci se, come scriveva Marguerite Yourcenar, «cerchiamo di entrare nella morte a occhi aperti» oppure alla cieca. Esiste una educazione alla consensualità? Il consenso è diventato o no il «limite invalicabile al trattamento sanitario»? (M. Foglia, Golden Hour del paziente: consenso biografico e dignità della vita, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 1-bis). La morte è l’esperienza della persona, un’esperienza medica o un’esperienza medicalizzata? Non tutti accettano una morte medicalizzata, perché non è detto che la medicina ad alta tecnologia – come la definì Sherwin Nuland, l’autore di How we die, chirurgo che per anni insegnò bioetica a Yale – valga la sofferenza procurata per prolungare un’esistenza. Chi può veramente dire se una persona accetti di esistere, dovendo rinunciare a vivere? E quindi che idea di vita abbiamo cresciuto? Il concetto di dignità della persona si accompagna o no a quello di identità? Se il legislatore legiferasse adesso, probabilmente dovrebbe esprimersi sulla base di un quadro di riferimento che vede il dolore come disumanizzante, come usurpatore dell’identità personale. Ma finirebbe per legiferare così perché a monte non c’è più la cultura all’accompagnamento del morire. Perché è stata persa questa cultura? Come mai è stata smarrita la certezza che non c’è sofferenza in grado di cancellare la dignità di una persona? Si può chiamare in causa il progresso medico-scientifico. Ci sono interventi medici che hanno un impatto rilevantissimo sulla vita, e non solo su quella del paziente, ma anche su quella dei familiari del paziente. Se non c’è un protocollo che dica dove e quando finisca il potere del medico, chi può decidere? La sentenza della Consulta ha in realtà avvertito questo vuoto culturale. Io ritengo che non abbia aperto all’eutanasia o al cosiddetto suicidio assistito, ma si sia riferita soltanto alla punibilità di chi presta il proprio aiuto ad una persona che chiede di morire, o abbia chiesto di essere lasciata andare, o abbia detto il suo no al prolungarsi di terapie indicate con l’infelicissimo termine di accanimento. Ma le domande restano tutte. E con loro i più contrastanti pensieri.
ativo è sempre un vulnus nell’organismo di uno Stato con pretese di civiltà, ma a volte può essere viceversa una garanzia. Labile o meno, ma una garanzia. È vero che una legge diventa a questo punto indispensabile, stante anche la manifesta «linea del Piave» dei medici cattolici, ma di fronte ad un Parlamento affaccendato con le scatole di merendine non risulta poi così stridente che spetti ai giudici, di volta in volta, esprimersi sui diversi casi. Persino il ministro degli esteri deve averlo intuito, perché ha auspicato, in un politichese asciutto, «un accordo per un testo equilibrato». Ha usato proprio questo termine: equilibrato. A dimostrazione della sua paura di «cattolico fervente», lui che contribuì a bocciare la legge sulle unioni civili, nonostante il sì di Rousseau, e del suo imbarazzo politico perché su questa eventuale legge si gioca la sorte di tutti gli esecutivi prossimi venturi. Per questo il problema è destinato, secondo me, a permanere a lungo, coperto e ben riscaldato dagli inutili scontri di principio. Cosa dovrebbero fare, più di questo, i giudici? Ora è semplice giubilare per la possibilità in più o sdegnarsi per il presunto smarrimento della ragione. Il punto primario è un altro ed è una questione di cultura. È dal 1975 che si parla della morte come fenomeno tecnico ottenuto interrompendo le cure: ne parlava un medievalista francese, Philippe Ariès, nel suo Essais sur l’histoire de la mort en Occident. Bisognerebbe ascoltare di più la serietà della storia. Bisognerebbe chiederci se, come scriveva Marguerite Yourcenar, «cerchiamo di entrare nella morte a occhi aperti» oppure alla cieca. Esiste una educazione alla consensualità? Il consenso è diventato o no il «limite invalicabile al trattamento sanitario»? (M. Foglia, Golden Hour del paziente: consenso biografico e dignità della vita, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 1-bis). La morte è l’esperienza della persona, un’esperienza medica o un’esperienza medicalizzata? Non tutti accettano una morte medicalizzata, perché non è detto che la medicina ad alta tecnologia – come la definì Sherwin Nuland, l’autore di How we die, chirurgo che per anni insegnò bioetica a Yale – valga la sofferenza procurata per prolungare un’esistenza. Chi può veramente dire se una persona accetti di esistere, dovendo rinunciare a vivere? E quindi che idea di vita abbiamo cresciuto? Il concetto di dignità della persona si accompagna o no a quello di identità? Se il legislatore legiferasse adesso, probabilmente dovrebbe esprimersi sulla base di un quadro di riferimento che vede il dolore come disumanizzante, come usurpatore dell’identità personale. Ma finirebbe per legiferare così perché a monte non c’è più la cultura all’accompagnamento del morire. Perché è stata persa questa cultura? Come mai è stata smarrita la certezza che non c’è sofferenza in grado di cancellare la dignità di una persona? Si può chiamare in causa il progresso medico-scientifico. Ci sono interventi medici che hanno un impatto rilevantissimo sulla vita, e non solo su quella del paziente, ma anche su quella dei familiari del paziente. Se non c’è un protocollo che dica dove e quando finisca il potere del medico, chi può decidere? La sentenza della Consulta ha in realtà avvertito questo vuoto culturale. Io ritengo che non abbia aperto all’eutanasia o al cosiddetto suicidio assistito, ma si sia riferita soltanto alla punibilità di chi presta il proprio aiuto ad una persona che chiede di morire, o abbia chiesto di essere lasciata andare, o abbia detto il suo no al prolungarsi di terapie indicate con l’infelicissimo termine di accanimento. Ma le domande restano tutte. E con loro i più contrastanti pensieri.
GUGLIELMO TINI


