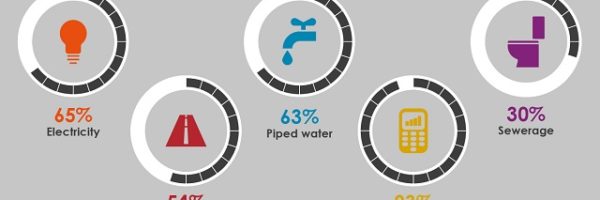Un esemplare episodio di integrazione nel mondo romano
Plinio il Vecchio nella Naturalis historia, XVIII, 41-43, riporta un fatto accaduto due secoli prima di lui per mostrare la virtù sottesa nel lavoro dei campi e la capacità che i Romani antichi ebbero di integrare il “diverso”. Ciò era possibile, però, se questi, con la sua opera, lungi dall’essere portatore di valori antitetici ed elemento di disgregazione della compagine nella quale si era inserito, si era mostrato, invece, all’altezza dei valori condivisi dalla società romana che con il suo comportamento esemplare aveva così contribuito a fortificare. L’episodio è ambientato nel mondo rurale che è il teatro reale e ideale dell’antico mos maiorum. “Gaio Furio Cresimo, uno schiavo liberato, poiché da un campo piccolissimo otteneva frutti molto più abbondanti che i suoi vicini da appezzamenti vastissimi, era guardato con grande sospetto come se attirasse con incantesimi i raccolti altrui. Citato in giudizio per questa ragione da Spurio Albino, edile curule, e temendo la condanna perché c’era da sottoporsi al voto delle tribù, portò nel foro tutta la sua attrezzatura agricola. Condusse la servitù, robusta e, come narra Pisone, ben tenuta e ben vestita, strumenti di ferro di buona fattura, pesanti zappe, vomeri ponderosi e buoi ben nutriti. Poi disse: ‘I miei malefici, o Quiriti, sono questi e non posso mostrarvi o portare nel foro le mie notti di lavoro, le veglie e i sudori’. Egli fu assolto all’unanimità. È fuori di dubbio che l’agricoltura non si fonda sulla spesa, ma sul lavoro e per questo i nostri avi sostenevano che in campo l’occhio del padrone è il fertilizzante migliore”.
L’accusa che aveva portato davanti ai giudici il liberto era di quelle che, se provata, avrebbe comportato la pena di morte come già sancito nelle Dodici Tavole. Infatti, il profitto conseguito col maleficio, che sconvolge l’ordine naturale delle cose, era frutto di arti magiche, nelle quali eccellevano gli orientali dal nome greco come Cresimo, che, perciò, suscitavano immediato il sospetto e l’odio degli agricoltori romani. Quando, però, il liberto riesce a dimostrare che il rigoglio delle sue messi non era frutto di magia ma di duro lavoro, allora il tribunale lo assolve all’unanimità e, così, lo fa entrare a vele spiegate nel consesso della Romanorum civitas. La sua presenza non potrà che fortificarla in quanto i valori espressi dalla condotta esemplare del liberto nel suo parvus agellus sono gli stessi che hanno fondato e fatto grande l’Urbe. Del resto già il cognomen, Cresimo, era indicativo del carattere della persona e della predisposizione ad essere apprezzata e, quindi, accolta perché questo soprannome greco, con cui era chiamato lo schiavo poi liberato da Gaio Furio, corrisponde al latino Valente. La nostra Cresima, come sacramento, certifica e attesta proprio la “valentia” del cristiano, perciò abile e arruolato, ad essere miles Christi.
Da questo episodio, portato ad esempio da Plinio il Vecchio, si possono trarre indicazioni significative riguardanti il mondo romano e, quindi, anche il nostro. La “romanità” emerge come sistema di valori certificati dalla qualità delle opere e fondati sulla comunanza del diritto. Infatti, già Cicerone, nel De re publica, I, XXV, 39, afferma che “La res publica è res populi e un popolo non è ogni ammasso di uomini messi assieme in qualunque modo ma un insieme di molti uniti nel voler osservare la giustizia e per comunanza di interessi”. Altresì, Sant’Agostino, nel De civitate Dei, XIX, 24, arricchisce e articola la definizione ciceroniana affermando che “Un popolo è un insieme di molti uomini ragionevoli uniti tra loro in modo concorde dall’amore delle medesime cose”. Da ciò si evince, però, che in base alle tante cose che tanti insiemi di uomini amano concordemente si formano altrettanti popoli. Tanti gli amori e le cose amate, altrettante le civitates. Questa definizione permetteva al Santo vescovo di Ippona di dare ragione della civitas Dei, fondata sull’amor Dei, ma anche della civitas Diaboli, figlia dell’amor sui, nondimeno pur lei civitas. Sempre e comunque è un amor il motore della costruzione della civitas che, platonicamente, è definita dal Santo dalla qualità dell’oggetto del desiderio. Quale è, dunque, l’amor fondante la “romanità” al cui confronto fu sottoposto l’operato del liberto Cresimo? È lo stesso che animò Catone il Censore e che trasuda da ogni riga del suo De agri coltura. Pietas e labor, che si manifestano attraverso il negotium, il non–otium, o officium, sono cardini della “romanità” e già di Roma stessa fondata con un rito di pietas augurale e con un atto di labor arativo. Questi, sottoposti alle rispettive discipline, sono i principi fondanti. Il liberto Cresimo, pur ellenizzato, aveva incarnate queste virtù testimoniate dalle sue opere e già significate dal suo cognomen. Roma ha vissuto anche dimensioni antitetiche, come il panem et circenses, “reddito di cittadinanza” di una plebe ormai inetta mantenuta di Stato. Questa appartiene, però, al periodo che vede dilagare, irreversibile, la decadenza della quale proprio le largitiones sono causa ed epifania. Invece, il principio fondante la “romanità” non ha subito la sorte dell’Impero perché il Virgilio delle Georgiche, I, 145-146, quello del labor omnia vicit improbus, è sopravvissuto alla fine del Mondo Antico ed è il filo rosso identitario che connota la civiltà dell’Europa cristiana latina e germanica. Ciò è avvenuto grazie a San Benedetto il cui Ordine ha evangelizzato e civilizzato i barbari del nord proprio con l’ora et labora, figlio di pietas e negotium, rendendoli protagonisti della rinascita dell’Europa. Pertanto, non si è mai interrotto nel mondo occidentale cristianizzato, che da Roma ha ricevuto la luce della civiltà, il valore positivo del lavoro. La Costituzione italiana che individua in questo il fondamento dell’istituzione repubblicana è figlia di Catone e di San Benedetto. L’Italia, però, omnium terrarum alumna, ovvero figlia di tutte le terre, è specchio e punto di approdo, e non da ieri e oggi più che mai, di tre continenti che convivono a fatica sul suo minuscolo territorio. Prima di essere romanizzata, buona parte di quella meridionale era stata già popolata da Greci e Cartaginesi per i quali il lavoro, a differenza dei Romani, quelli antichi, era una faccenda da caricare sulle spalle degli schiavi. Lo stesso nome del luogo del lavoro manuale, ergasterion, dal quale il nostro “ergastolo” proviene, ne esprime chiaramente il concetto negativo di stigma servile. Altresì, proprio il contrario, l’otium, tanto disprezzato da Catone amante del negotium e demonizzato da San Benedetto come inimica otiositas, strumento del Demonio e padre dei vizi, era la dimensione ideale del vivere propria dei liberi. Questi erano tali proprio perché “liberati” dalle cure del lavoro che gravando sulle spalle altrui permetteva loro di vivere oziando, tant’è che il verbo scholàzein, oziare, dal quale deriva la nostra “scuola”, esprime la positiva e apprezzata condizione di privilegio. Non a caso, la democrazia nell’Atene di Pericle si afferma proprio grazie al “reddito di cittadinanza” esteso ai ceti popolari per permetter loro di partecipare alle assemblee. Le stesse “arti liberali” sono tali proprio perché chi le pratica lo può fare avendo alle spalle già risolti dai servi i problemi della sussistenza. I termini dialettali in quella che fu la Magna Grecia, fatica’ e travagghiari, trasudano anche oggi la considerazione negativa del lavoro. Inoltre, le attualissime e antichissime camorra, ‘ndrangheta e mafia stanno lì coi loro nomi, sannita, greco e cartaginese, a mostrare l’origine preromana che ben oltre duemila anni di storia patria non sono riusciti né ad offuscare né a debellare. Queste non sono frutti accidentali di quelle regioni sulle quali insistono le loro radici e gran parte delle chiome che si sono poi estese altrove con l’irradiarsi nel mondo dei nativi di queste regioni. Mostrano, e oggi non sono più da sole a farlo, quante civitates coesistono nella nostra Penisola oltre a quella fondata sulla premessa catoniana e benedettina che ha connotato l’istituzione repubblicana e già da prima ha animato tanta parte del Risorgimento nazionale. Preesistenze consolidate del genere nei tanti popoli dell’Italia preunitaria fecero dire a Massimo D’Azeglio che, fatta l’Italia, si sarebbe dovuto fare gli Italiani. A questa realtà composita, che 150 anni di storia unitaria non sono riusciti a tutt’oggi ad uniformare nei valori fondanti, anche grazie alla deriva centrifuga seguita alla disfatta nell’ultimo conflitto mondiale e ai modi dell’Unione Europea, si aggiunge la gente che da tutto il mondo oggi è arrivata e sta arrivando sulle itale sponde. Questa è spesso segnata e già unificata al proprio interno da legami etnici, consortili e religiosi, fondamenta di altrettante civitates, in molti casi ferrei, feroci e inconciliabili non solo praticamente con quanto di umanisticamente unico ha prodotto in secoli di civiltà l’Italia. Nel mentre, è stato in modo consapevole quanto colpevole smantellato lo spessore trimillenario dell’identità nazionale con l’espunzione avvenuta da tempo della lingua e della storia romana dalla coscienza collettiva. Inoltre, è venuto meno in patria anche il primato della lingua italiana inquinata prima e sostituita poi progressivamente dall’inglese transnazionale imposto ad ogni costo e con tutti i mezzi della comunicazione. Si può, così, solo vagamente immaginare la Babele centrifuga e schizofrenica avvenire mancando oggi in Italia un ubi consistam identitario indiscusso, universalmente condiviso e introiettato come quello che l’episodio di integrazione narrato da Plinio il Vecchio testimonia e sottende. Difficilmente, alla fine, potrà esserci un populus, sia nell’accezione ciceroniana di comunanza di diritto ed interessi, sia in quella agostiniana di amore concorde per le medesime cose.
amor il motore della costruzione della civitas che, platonicamente, è definita dal Santo dalla qualità dell’oggetto del desiderio. Quale è, dunque, l’amor fondante la “romanità” al cui confronto fu sottoposto l’operato del liberto Cresimo? È lo stesso che animò Catone il Censore e che trasuda da ogni riga del suo De agri coltura. Pietas e labor, che si manifestano attraverso il negotium, il non–otium, o officium, sono cardini della “romanità” e già di Roma stessa fondata con un rito di pietas augurale e con un atto di labor arativo. Questi, sottoposti alle rispettive discipline, sono i principi fondanti. Il liberto Cresimo, pur ellenizzato, aveva incarnate queste virtù testimoniate dalle sue opere e già significate dal suo cognomen. Roma ha vissuto anche dimensioni antitetiche, come il panem et circenses, “reddito di cittadinanza” di una plebe ormai inetta mantenuta di Stato. Questa appartiene, però, al periodo che vede dilagare, irreversibile, la decadenza della quale proprio le largitiones sono causa ed epifania. Invece, il principio fondante la “romanità” non ha subito la sorte dell’Impero perché il Virgilio delle Georgiche, I, 145-146, quello del labor omnia vicit improbus, è sopravvissuto alla fine del Mondo Antico ed è il filo rosso identitario che connota la civiltà dell’Europa cristiana latina e germanica. Ciò è avvenuto grazie a San Benedetto il cui Ordine ha evangelizzato e civilizzato i barbari del nord proprio con l’ora et labora, figlio di pietas e negotium, rendendoli protagonisti della rinascita dell’Europa. Pertanto, non si è mai interrotto nel mondo occidentale cristianizzato, che da Roma ha ricevuto la luce della civiltà, il valore positivo del lavoro. La Costituzione italiana che individua in questo il fondamento dell’istituzione repubblicana è figlia di Catone e di San Benedetto. L’Italia, però, omnium terrarum alumna, ovvero figlia di tutte le terre, è specchio e punto di approdo, e non da ieri e oggi più che mai, di tre continenti che convivono a fatica sul suo minuscolo territorio. Prima di essere romanizzata, buona parte di quella meridionale era stata già popolata da Greci e Cartaginesi per i quali il lavoro, a differenza dei Romani, quelli antichi, era una faccenda da caricare sulle spalle degli schiavi. Lo stesso nome del luogo del lavoro manuale, ergasterion, dal quale il nostro “ergastolo” proviene, ne esprime chiaramente il concetto negativo di stigma servile. Altresì, proprio il contrario, l’otium, tanto disprezzato da Catone amante del negotium e demonizzato da San Benedetto come inimica otiositas, strumento del Demonio e padre dei vizi, era la dimensione ideale del vivere propria dei liberi. Questi erano tali proprio perché “liberati” dalle cure del lavoro che gravando sulle spalle altrui permetteva loro di vivere oziando, tant’è che il verbo scholàzein, oziare, dal quale deriva la nostra “scuola”, esprime la positiva e apprezzata condizione di privilegio. Non a caso, la democrazia nell’Atene di Pericle si afferma proprio grazie al “reddito di cittadinanza” esteso ai ceti popolari per permetter loro di partecipare alle assemblee. Le stesse “arti liberali” sono tali proprio perché chi le pratica lo può fare avendo alle spalle già risolti dai servi i problemi della sussistenza. I termini dialettali in quella che fu la Magna Grecia, fatica’ e travagghiari, trasudano anche oggi la considerazione negativa del lavoro. Inoltre, le attualissime e antichissime camorra, ‘ndrangheta e mafia stanno lì coi loro nomi, sannita, greco e cartaginese, a mostrare l’origine preromana che ben oltre duemila anni di storia patria non sono riusciti né ad offuscare né a debellare. Queste non sono frutti accidentali di quelle regioni sulle quali insistono le loro radici e gran parte delle chiome che si sono poi estese altrove con l’irradiarsi nel mondo dei nativi di queste regioni. Mostrano, e oggi non sono più da sole a farlo, quante civitates coesistono nella nostra Penisola oltre a quella fondata sulla premessa catoniana e benedettina che ha connotato l’istituzione repubblicana e già da prima ha animato tanta parte del Risorgimento nazionale. Preesistenze consolidate del genere nei tanti popoli dell’Italia preunitaria fecero dire a Massimo D’Azeglio che, fatta l’Italia, si sarebbe dovuto fare gli Italiani. A questa realtà composita, che 150 anni di storia unitaria non sono riusciti a tutt’oggi ad uniformare nei valori fondanti, anche grazie alla deriva centrifuga seguita alla disfatta nell’ultimo conflitto mondiale e ai modi dell’Unione Europea, si aggiunge la gente che da tutto il mondo oggi è arrivata e sta arrivando sulle itale sponde. Questa è spesso segnata e già unificata al proprio interno da legami etnici, consortili e religiosi, fondamenta di altrettante civitates, in molti casi ferrei, feroci e inconciliabili non solo praticamente con quanto di umanisticamente unico ha prodotto in secoli di civiltà l’Italia. Nel mentre, è stato in modo consapevole quanto colpevole smantellato lo spessore trimillenario dell’identità nazionale con l’espunzione avvenuta da tempo della lingua e della storia romana dalla coscienza collettiva. Inoltre, è venuto meno in patria anche il primato della lingua italiana inquinata prima e sostituita poi progressivamente dall’inglese transnazionale imposto ad ogni costo e con tutti i mezzi della comunicazione. Si può, così, solo vagamente immaginare la Babele centrifuga e schizofrenica avvenire mancando oggi in Italia un ubi consistam identitario indiscusso, universalmente condiviso e introiettato come quello che l’episodio di integrazione narrato da Plinio il Vecchio testimonia e sottende. Difficilmente, alla fine, potrà esserci un populus, sia nell’accezione ciceroniana di comunanza di diritto ed interessi, sia in quella agostiniana di amore concorde per le medesime cose.
Didascalia dell’immagine:
Motto sulla facciata della casa natale di Feliciano Scarpellini al numero 42 di via Mazzini.
IVO PICCHIARELLI